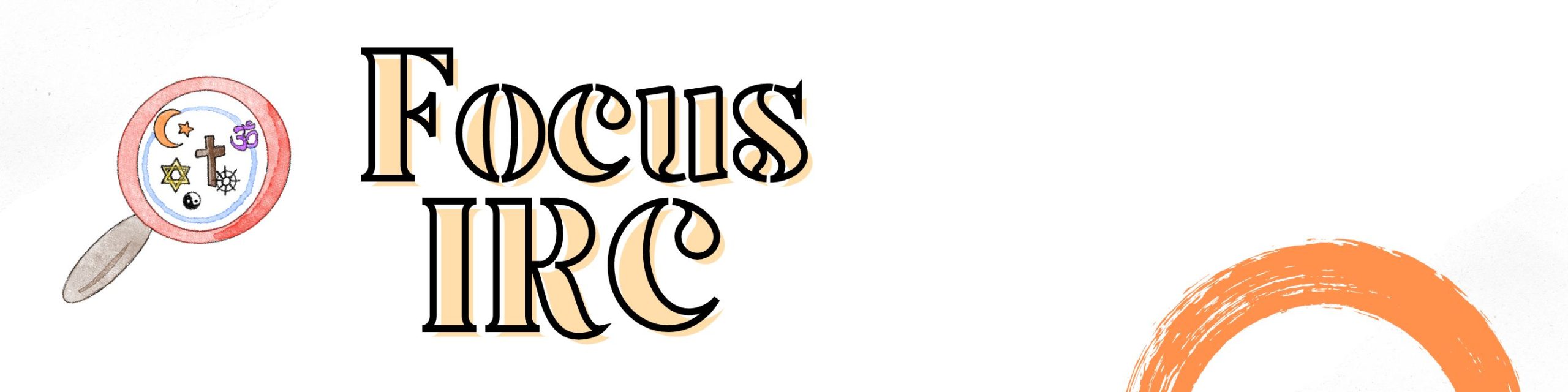Il profilo giuridico dell’Insegnamento della Religione Cattolica
Fabio Gambetti[1]
Abstract
L’articolo ripercorre tramite le norme le principali fasi storiche dell’Insegnamento della Religione in Italia, sottolineandone la specificità. Attraverso il percorso storico si coglie la fluidità, con cui tale materia è entrata a far parte dell’istruzione, e le caratteristiche del contributo che può dare alla formazione culturale degli studenti, senza sottacere talune criticità tuttora oggetto di discussione.
Introduzione
Nel 1122 col concordato di Worms si concluse la lotta per le investiture. L’accordo raggiunto tra l’imperatore Enrico V e il papa Callisto II, stabilì che il sovrano avrebbe rinunciato al diritto di nominare o investire direttamente vescovi e prelati, mentre la nomina sarebbe stata lasciata alle autorità ecclesiastiche. L’imperatore mantenne tuttavia un ruolo solo formale nel processo, confermando di fatto le nomine effettuate dalla Chiesa.
Tale accordo contribuì a definire la relazione tra Chiesa e Stato nell’Europa medievale, sancendo il principio che le nomine ecclesiastiche erano prerogativa della Chiesa, ma richiedevano l’approvazione formale delle autorità civili. La dialettica Chiesa-Stato è proseguita nei secoli con alterne vicende e periodi e pare si possa dire che tutt’oggi il modello di Worms sia riferimento per la gestione dell’Insegnamento di Religione nelle scuole italiane.
1. Sintesi delle fasi dell’insegnamento della religione cattolica in Italia
L’insegnamento della religione (IdR) cattolica nelle scuole rappresenta una componente significativa del sistema educativo nazionale, riflettendo l’importante legame storico e culturale tra la Chiesa cattolica e l’Italia. La presenza di tale materia all’interno delle istituzioni scolastiche è un elemento caratterizzante del contesto educativo. L’attività educativa della Chiesa cattolica nell’istruzione in Italia ha infatti radici profonde nella storia del Paese. Ordini e Istituti religiosi nei secoli hanno formato ed educato le nuove generazioni. La nascita dello Stato unitario vide nella breccia di Porta Pia un momento dotato anche di una forte valenza simbolica dei rapporti tra Stato e Chiesa; dopo il non expedit di Pio IX seguirono differenti fasi di cambiamento e di collaborazione.
Il primo riferimento normativo in materia IdR è costituito dalla Legge Casati, la n.° 3275 del 13 novembre 1859, in vigore fino al 1923. L’art. 193 prevedeva che «l’istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione per ciascun Stabilimento, secondo le norme da determinarsi con un Regolamento». Il successivo art. 315 elenca le materie da impartire alle elementari e tra esse figura «l’insegnamento religioso». In base alla normativa dell’allora Regno Sabaudo l’IdR è obbligatorio e già individua i differenti ruoli dei docenti: sono direttori spirituali, ovvero sacerdoti, a nomina del Ministero; competenza semestrale del parroco l’esame della preparazione conseguita dagli allievi nell’insegnamento religioso, possibilità d’esonero previa richiesta scritta dei genitori con firma autenticata. I programmi erano stabiliti con appositi regolamenti e ordinanze.
Successivamente il nuovo Regno italiano con la Circolare Correnti del 29 settembre del 1870 rese facoltativo l’IdR alle elementari: erano gli anni della Terza Guerra d’Indipendenza che portò, tra l’altro, a Roma Capitale. Nel 1877 la Legge Casati rese obbligatorio il triennio delle elementari e l’IdR fu sostituito dall’insegnamento di nozioni in merito ai doveri dell’uomo e del cittadino. Il Consiglio di Stato con diverse sentenze sancì però l’obbligo per i Comuni di assicurare l’insegnamento a richiesta delle famiglie.
Il Regio decreto n. 2185 del 1° ottobre 1923, la cd. Riforma Gentile, prevedette l’IdR alle elementari definendolo «fondamento e coronamento dell’istruzione di quel settore di scuola». Il successivo Testo Unico n. 577 del 05/02/1928 stabilì la possibilità di essere esonerati previa richiesta scritta dei genitori. La Riforma Gentile fu recepita per quanto attiene l’IdR nei cd. Patti Lateranensi, ovvero nel Concordato del 1929 ratificato con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929. L’IdR divenne obbligatorio in tutti i gradi scolastici pre-universitari, con l’eccezione della scuola dell’infanzia. I programmi erano concordati tra Chiesa Cattolica e Stato italiano, e gli insegnanti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, al pari dei libri di testo.
Nel secondo dopoguerra la Costituzione Repubblicana recepì i Patti Lateranensi affermando che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi» (art. 7). Nel testo costituzionale non si trovano espliciti riferimenti all’IdR, i cui principi vanno dunque rintracciati nel Concordato e nelle Intese attuative.
Il 18 febbraio 1984 il Concordato è stato rivisto e ratificato dalla Legge n. 121 del 25 marzo 1985, che in merito all’IdR da un lato ne conferma l’identità e le motivazioni, dall’altro segna una discontinuità importante: esso entra nella scuola nell’ambito delle finalità della scuola stessa e la sua presenza è giustificata da motivazioni di ordine storico e culturale. L’art. 9.2 afferma infatti che l’Italia riconosce il valore della cultura religiosa e che fanno parte del nostro patrimonio culturale i principi del cattolicesimo. L’IdR non è più pertanto considerato “fondamento e coronamento” dell’istruzione bensì parte della cultura italiana. Contestualmente esso viene esteso alla scuola dell’infanzia.
La citata Legge 121/1985 prevede che lo Stato continui «ad assicurare l’IdR nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento» (art. 9.2). Se prima del 1984 l’IdR era obbligatorio con la possibilità di esonero, ora diventa un insegnamento opzionale: la Legge precisa infatti che, all’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono la scelta se avvalersene o meno e puntualizza che l’opzione non può dare luogo a forme di discriminazione. La recente O.M. sulle iscrizioni a.s. 2024/25 n.° 40055 del 12 dicembre 2023 precisa che i genitori esprimeranno la scelta tramite la Piattaforma Unica nel mese di giugno 2024. Tranne che all’infanzia, dove l’opzione va espressa ogni anno, nel primo e nel secondo ciclo la scelta effettuata a inizio ciclo vale anche per gli anni successivi del medesimo grado scolastico. Il DPR 751/1985 stabilisce tuttavia la possibilità, su richiesta, di modificare la scelta compiuta all’atto dell’iscrizione.
2. Profilo giuridico dei docenti di religione cattolica
I docenti di religione cattolica svolgono un ruolo importante nell’offrire una formazione culturale in materia religiosa agli studenti. Devono essere in possesso di specifici requisiti e sono individuati dalle autorità ecclesiastiche locali seguendo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) in accordo con i dirigenti scolastici.
Va innanzitutto ricordato che gli insegnanti di Religione Cattolica (IRC) devono rispettare tutte le disposizioni proprie degli altri insegnanti, riguardanti la didattica e la vita scolastica (ad esempio, privacy, sicurezza, trasparenza, doveri lavorativi, ecc.).
La peculiarità dell’IRC, come ricordato, consiste nella idoneità riconosciuta dal Vescovo territorialmente competente (il cd. Ordinario diocesano), e nella nomina d’intesa con l’Autorità scolastica (il dirigente scolastico). Con la Legge n. 186 del 18 luglio 2003 lo stato giuridico è cambiato, perché è previsto anche per tali insegnanti il contratto a tempo indeterminato anziché annuale, previo il superamento di un concorso per esami e titoli. Stante la peculiarità dell’idoneità all’insegnamento di competenza dell’Ordinario diocesano, sono previsti distinti ruoli regionali corrispondenti ai differenti cicli d’istruzione e ai territori delle Diocesi anziché degli Ambiti territoriali (ex province). I posti disponibili per i contratti a tempo indeterminato sono pari al 70% dei posti IRC complessivamente attivi.
Al pari degli altri docenti, a domanda possono fruire della mobilità territoriale e della differente utilizzazione prevista dall’art. 33 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Il rimanente 30% di posti non coperti da docenti con contratto a tempo indeterminato viene assegnato con incarichi annuali. Non essendo a priori prevista la copertura al 100% dei posti, il CCNL 1995 ha previsto all’art. 47, comma 6, il diritto alla riconferma del contratto ove sussistano le ore d’insegnamento. Qualora poi il docente t.d. svolga lezione con orario cattedra completo e abbia almeno quattro anni di servizio, ai sensi dell’art. 53 della Legge 312/1980 fruisce dei medesimi diritti in materia di ferie, permessi, assenze e aspettative di cui beneficiano i colleghi con contratto t.i.
L’IRC partecipa a pieno titolo a tutti gli organi scolastici, ai sensi dell’art. 309 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, con uguali diritti e doveri.
Quanto alla peculiarità di tale tipologia di docente, ovvero l’essere riconosciuto idoneo dal Vescovo diocesano, sussistono precisi criteri indicati dal Codice di diritto canonico al can. 804.2: «siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica». Non basta quindi conoscere la teologia cattolica e la pedagogia, sembra dire il Codice; occorre anche conformare la propria vita al Magistero. Al chiarimento di tale canone ha provveduto la CEI nella 34ª assemblea generale del 1991. I Vescovi italiani hanno infatti spiegato che il primo requisito consiste nella «conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della Rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa»; il secondo nel vivere «coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale» e che comportamenti pubblici e notori non siano «in contrasto con la morale cattolica»; l’ultimo «la specifica capacità di insegnare che è comprovata dagli studi effettuati in vista dell’ordine di scuola in cui il docente può svolgere la sua attività nel modo migliore». L’idoneità, una volta acquisita, è permanente salvo revoca episcopale, che diviene definitiva dopo una specifica procedura. Se l’IRC fruisce di un contratto a tempo indeterminato, sarà compito dello Stato italiano, in applicazione dell’art. 4, comma 3 della Legge 186/2003 assegnare il docente non più idoneo ad altro incarico per il quale abbia titolo. Viceversa, se trattasi di docente con contrato a tempo determinato, non è previsto un ricollocamento d’ufficio.
L’art. 4 dell’Intesa Stato-Chiesa siglata in attuazione del Concordato il 28 giugno 2012 tra il Presidente della CEI, card. Bagnasco, e il Ministro dell’Istruzione, prof. Profumo, indica come titoli validi tutti quelli utilizzati fino all’a. s. 2017/18, prevedendo solo dal successivo anno l’obbligo della laurea magistrale e/o del baccalaureato e/o titolo superiore integrato con specifici esami per il secondo ciclo e per la scuola media, mentre alla primaria possono insegnare RC anche docenti della sezione in possesso di uno specifico master biennale[2]. Sono altresì riconosciuti validi altri titoli particolari quali l’attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore.
3. La valutazione dell’IdR
Al pari di ogni disciplina scolastica anche per l’IdR è prevista una valutazione, ma essa ha modalità specifiche. I riferimenti normativi si trovano innanzitutto nell’art. 309, comma 4 del D. Lgs. 297/1994, in base al quale: «Per l’insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne ritrae».
Il DPR 112/2009, all’art. 2 recepisce di fatto il citato articolo del Testo Unico 297/1994, salvaguardando però eventuali future modifiche dell’Intesa vigente, ovvero quella del 2012[3]. Al riguardo è bene sottolineare che la norma non prevede un voto numerico, bensì la formulazione di un giudizio. La materia non è inoltre oggetto di esame a fine ciclo e la valutazione è trascritta su un’apposita scheda separata dalla pagella.
Quest’ultima peculiarità è stata ripresa anche nel D. Lgs. 62/2017 che, ad esempio, per l’ammissione all’esame di licenza media all’art. 6, comma 4 prevede che «Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale». Di analogo tenore è il successivo art. 12 che regola l’ammissione all’esame di Stato, la cd. ‘maturità’[4].
4. Alcune questioni aperte
Nella prassi si riscontrano alcune questioni che, col mutare delle norme e della società, sono talvolta motivo di discussione quando non di contenzioso.
Una prima questione riguarda la collocazione oraria dell’ora di religione. Trattandosi di materia opzionale, si sono verificati casi in cui è stata posta alla prima o all’ultima ora, disincentivando così l’opzione dell’IdR. Nel merito è intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze 203/1989, 13/1991 e 290/1992, affermando legittima la collocazione dell’IdR nell’orario scolastico ordinario, come per le altre materie. Con la circolare n. 9 del 18/1/1991 il Ministero la fornito le istruzioni attuative della citata sentenza 13/1991.
Altro tema controverso riguarda il cd. credito scolastico a favore di coloro che si avvalgono di tale insegnamento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del DPR 122/2009, con l’obiezione relativa alla disparità di trattamento a danno di chi non se ne avvale. Dopo un paio di sentenze di segno opposto emesse dal TAR del Lazio, il Consiglio di Stato con sentenza 2749/2010 ha stabilito che la mancata valutazione dell’IRC ««rischierebbe di dare luogo ad una sorta di discriminazione alla rovescia», in quanto è data la possibilità di seguire attività alternative parimenti valutabili per il credito scolastico.
Oggetto di contenzioso anche la posizione dei ricusanti tale insegnamento in corso d’anno. Al riguardo sono state emesse alcune sentenze da parte di altrettanti TAR che ritengono che l’obbligo sussista per lo Stato di assicurare l’IdR, ma non per lo studente di seguirlo per l’intero anno, «non attenendo l’insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti» come, ratificato dal Consiglio di Stato (sentenza n.° 4634/2018).
Un ultimo aspetto da sottolineare riguarda il fatto che le linee guida dell’IdR prevedono anche il dialogo interreligioso, ma è pur vero che a insegnarlo è un docente cattolico. In attuazione dell’art. 8 della Costituzione[5], sono state al momento stipulate dodici intese con altrettante confessioni religiose (esclusa l’Islam in quanto manca di un’associazione unitaria che la rappresenti), in base alle quali possono tenere lezioni extracurriculari sul proprio credo ma con oneri a carico delle stesse. Alcune Intese prevedono inoltre la tutela delle festività religiose quali il riposo sabbatico.
Conclusione
In conclusione si può ritenere che, seppur con alterne vicende, l’IdR in Italia sia un elemento significativo del contesto educativo, contribuendo alla formazione degli studenti. La tradizione culturale e storica del nostro Paese è strettamente legata al cattolicesimo, e l’inclusione di questa disciplina nelle scuole offre agli studenti la possibilità di comprendere meglio il contesto in cui vivono. Basti pensare alle differenti forme artistiche, agli edifici oltre al contributo dato dai cristiani al formarsi della società, al costituirsi di istituzioni quali ospedali, enti di beneficenza, ma anche all’apporto di alcuni valori entrati a far parte della Costituzione.
L’IdR può svolgere un ruolo importante nel promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la giustizia sociale e l’etica personale. Offre inoltre agli studenti uno spazio di riflessione e dialogo su questioni morali e spirituali, favorendo lo sviluppo di una coscienza critica. È essenziale, tuttavia, garantire che l’insegnamento dell’IdR avvenga nel rispetto della laicità dello Stato e della libertà di pensiero degli studenti. La promozione di un approccio aperto e inclusivo, che consenta agli alunni di esplorare le proprie convinzioni e opinioni, può arricchire l’esperienza educativa e contribuire a formare cittadini consapevoli e responsabili.
La sfida consiste nel trovare un equilibrio tra la valorizzazione della tradizione culturale e religiosa del Paese e il rispetto della diversità e della laicità dell’istruzione pubblica. Un approccio equilibrato può contribuire a plasmare un ambiente educativo che rifletta la complessità della società italiana, promuovendo al contempo la formazione di individui attenti, eticamente responsabili e consapevoli della propria identità culturale.[6]
[1] Docente dell’Istituto di Scienze Religiose “Vitale e Agricola”, Bologna.
[2] Cfr. Intesa MIRU-CEI, art. 4.2.1 sg.
[3] Cfr. DPR 122/2009, art. 2, comma 4: «La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121».
[4] D. Lgs. 62/2017, art. 13, comma 2, lettera D: «Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.»
[5] «Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
[6] Cfr., art. 1 D. Lgs. 297/1994: «1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni».
Per un oltre alle norme espressamente citate nell’articolo, si veda: S. Cicatelli, Prontuario giuridico IRC, Queriniana, Brescia 2015; F. G. Corbetta, Compendio di legislazione scolastica, Nel Diritto Editore, Molfetta 2020; J. Pierantozzi, Imparare la legislazione scolastica, Maggioli, Rimini 2023; M. Davì – E. Rinaudo – G. Bellien – L. Raspi – G. Migliorini – R. Romio, L’insegnamento di IRC. Dalla teoria alla pratica, dalla pratica alla teoria: l’IDR in cattedra, EDB, Bologna 2023.